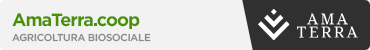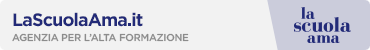Piccole cose di enormi tragedie

Di Gian Mario Bachetti.
Sono tornato ad Ascoli, la prima volta dopo il terremoto, durante i primi di novembre. C’erano state altre scosse, la terra aveva tremato ancora e buttato giù altri muri e altri tetti. Fino a qualche mese fa ricordavo i giorni, gli epicentri e le magnitudo. Ora no, ho dimenticato. Non voglio googlare.
Continuavo a sentirmi in colpa: erano passati mesi e non avevo messo piede nella mia città, una città di cui seguivo i tormenti dal buco della serratura offertomi dai gruppi Facebook, gli status, gli hashtag, le chat di gruppo su Whatsapp.
Aspettavo l’autobus a Tiburtina. Quell’autobus che si sarebbe piegato lungo le vertebre della Salaria, una strada che per la prima volta in quasi dieci anni avrei visto diversa, con la frana sotto Pescara a sfigurarne i lineamenti.
Ricevetti una chiamata di mia madre mentre ero allo stallo numero 18. Diceva che avrei dormito a casa dei nonni, perché è a un piano più basso del nostro appartamento e perché anche lei dormiva con la madre - per non lasciarla sola, per stare tutti insieme. Perché non si sa mai.
Quando la sera sono uscito per incontrare i miei amici, si è raccomandata di non chiudere il chiavistello della porta d’ingresso quando fossi rientrato. Metti che dobbiamo andare via all’improvviso.
Sono riuscito a salire ad Arquata: era una giornata ventosa e i tiranti delle tende facevano un rumore assordante, uno sciame meccanico che ronzava contro la plastica blu. Come se tutto il resto non fosse sufficiente, c’era anche quel maledetto pandemonio di ferraglia.
È drammatico e disarmante il modo in cui non si possano capire certe cose - una normalità che sembrava fantascienza.
Posso vedere i video di mille droni sorvolare paesi di cui sono rimasti pochi calcinacci, le bare al telegiornale, le mani sporche di polvere; ma nulla mi ha fatto capire quanto un evento del genere abbia condizionato le vite di migliaia di persone come il monito di mia madre a non chiudere la porta e il rumore dei tiranti. Così come non ho capito la gigantesca follia delle deportazioni naziste finché non mi hanno raccontato che nei treni che portavano in Polonia l’unico cibo disponibile, per giorni e giorni di viaggio d’estate in vagoni di ferro, fossero acciughe sotto sale; perché il caldo e la sete posso capirli, ma non ho idea di cosa significhi lavorare per ore e ore di fila senza cibo, seminudo nella neve, per poi morire di stenti, o con il gas che invade i polmoni. Come non avevo idea di cosa significasse sbarcare dal Nord Africa finché non ho parlato con un diciassettenne del Mali partito quattro anni prima da casa; come se io avessi trascorso i primi anni di liceo ad attraversare il mondo a piedi, subendo l’innominabile, invece di tradurre Seneca e ubriacarmi col Cynar liscio all’aperitivo.
Ora sono in un locale con un vinile a rumore di fondo, circondato da ragazzi e ragazze che bevono centrifughe e caffè americani. Tra qualche minuto tornerò nel mio appartamento soppalcato, forse vedrò degli amici per cena. A qualche chilometro da qui c’è gente che ha perso tutto, dalle case alle tazzine del caffè, che vive in tende, in appartamenti altrui, in box prefabbricati e il non avere neppure la più pallida idea di cosa significhi mi butta giù, ché nelle piccole cose di tutti i giorni si percepiscono – credo - le tragedie più grandi.